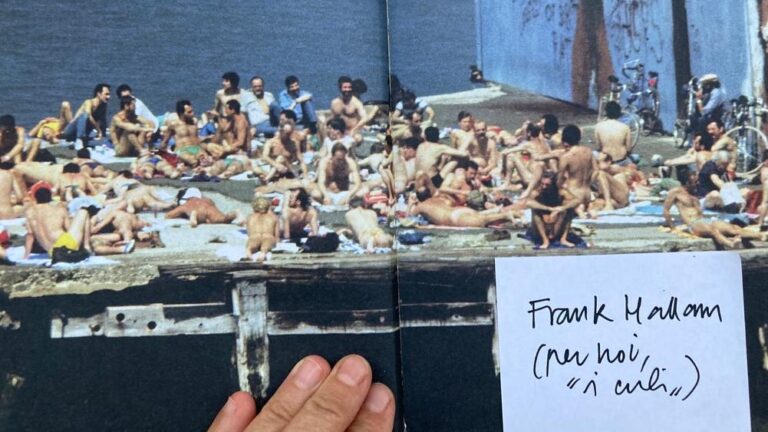Attilio Scarpellini in dialogo con Silvia Rampelli
Silvia Rampelli con il progetto di ricerca performativa indipendente da lei fondato, Habillé d’eau, è presente a Short Theatre 2023 con Body Farm ospitato per l’occasione al Monte dei Cocci.
∴
Body Farm, per come lo ricordo, esprime una singolare polarità: da una parte si rifà alla pratica e al rigore della scienza – fin dal titolo, le Body Farms americane sono Centri di Antropologia Forense dove vengono raccolti i corpi in decomposizione per essere studiati – dall’altra, non ho mai visto una performance o un’azione teatrale produrre negli spettatori degli effetti emotivamente altrettanto intensi, in un arco di reazioni che va dallo stupore al raccoglimento, dalla contemplazione al mormorio di una preghiera che immagino senza parole. Qualcosa provoca una rottura dell’asse oggettiva della visione – out of joint – un’improvvisa irruzione di poesia. Vorrei chiederti, per cominciare, se di questa polarità eri consapevole prima del suo accadere, se rientrava nei piani del lavoro determinare un conflitto, agirlo…
Body Farm è un esperimento, nel senso che pone un dato, un insieme di circostanze, e ne osserva gli effetti. Tematizza la risposta dello spettatore al dato, il farsi dell’esperienza. Mette in campo la prossimità dei corpi e uno spazio e un tempo sufficientemente ampi per lasciare a ogni singola persona l’eventualità dell’incontro, le possibili modalità di attuazione. Parallelamente Body Farm tende a una zona di esperienza del tutto estranea alla spettacolarità. Come ho scritto, si tratta di un luogo per la contemplazione, di un evento apparente e del suo sciame percettivo. E l’evento che si mostra è una disposizione di corpi, configurati in azioni formalmente definite. Lo spettatore, partecipa dell’esperimento, varca un confine, penetra nel luogo performativo invadendolo, è attore di una circostanza aperta, che determina nella misura in cui risponde con il proprio personale, soggettivo stare, attraversare…
Ma i corpi, loro, non rispondono, restano nella loro alterità, come stelle fisse in un cangiante firmamento…
I corpi sono in uno stato di consegna assoluta, inermi, non oppongono resistenza se non nell’essere materia. Si espongono in effetti non solo alla visione ma, come è accaduto a Rosignano, alla possibile violazione del personale spazio fisico. L’inermità, la resa, il disarmo dei corpi, è una delle questioni fondamentali in Body Farm.
Si potrebbe dire con Wyslawa Szymborska che il corpo c’è, e c’è, e c’è/ e non trova riparo…
All’origine, la domanda, tanto complessa quanto elementare – votata dunque al disastro – suonava semplicemente: cosa genera nell’altro l’esposizione di un corpo, di un corpo reso al fatto, disarmato, immobile? Questa chiamata del corpo, nelle condizioni in cui il vivente sembra attualmente dispiegarsi, agisce ancora e, soprattutto, come? La risposta, le risposte, la disposizione a rispondere generata da questa chiamata, è esattamente il luogo – anche invisibile – della performance.
La questione del disarmo del corpo ha a che fare con una presa di consapevolezza, che nel corso dell’esperienza si fa più nitida e attraversa l’intero campo dell’esistere: è ontologica, sociale, teatrale, se vogliamo artistica, ed è la consapevolezza che, a fronte di questo disarmo, l’azione sia arma. E che l’umano attraverso l’azione, non solo si esprime e si definisce, ma si maschera: togliere l’azione significa togliere la maschera, togliere l’arma, rinunciare a ciò che in un certo senso costituisce il nucleo dell’esistenza umana, cioè la progettualità. Sospendere l’azione vuol dire perdere l’intenzionalità e l’intenzionalità è il progetto umano, è ciò che fa dell’uomo l’uomo. Togliere l’azione significa portare la condizione umana a una condizione di puro esistente…
…a una condizione di nuda vita.
Esatto. E questo è un elemento centrale e scatenante: nell’esperienza di Rosignano, che è ovviamente non replicabile, l’avvicinamento ai corpi inermi nel tempo – perché la durata esercita un’azione sullo spettatore – ha inaspettatamente disinnescato un freno…
…un freno tipico dell’umano che potremmo identificare con il respicio, con il rispetto. In uno dei suoi scritti, Jerzy Grotowski ricorda il filmato del rogo del bonzo vietnamita Thich Quang Duc e nota che i suoi compagni si tengono in una zona al di qua dell’azione, a una certa distanza, si comportano come testimoni.
L’esporsi nella durata e alla durata ha creato le condizioni per uno spostamento sensoriale, l’innesco inaspettato di un’attitudine tattile, che ha comportato in alcuni casi una profanazione dello spazio dell’altro, un contatto che si è espresso in forme a volte rispettose, altre meno…
Che però tu, presente sul campo, non hai in alcun modo interdetto…
Mi sono trattenuta all’ingresso, sul crinale, non vedevo tutto ciò che accadeva, ma non sarei comunque intervenuta, proprio perché il principio era quello della consegna. La mia stessa presenza, come ho avuto modo di rendermi conto, poteva esercitare una forma di controllo o di esempio, il pubblico poteva sentirsi guardato da me che guardavo… Sarebbe forse corretto che io non ci fossi, giusto eliminare uno sguardo esterno potenzialmente condizionante.
Body Farm, come hai già detto, è un’azione e si svolge nel tempo, produce e si produce in una durata. Ma è una durata prefissata, come quella di uno spettacolo teatrale, o una durata instabile, aleatoria, come quella di una performance o di un’installazione?
Body Farm ha una durata prefissata di un’ora. L’unica indicazione che il pubblico riceve è che l’azione termina al calare del sole, quando di fatto il sole scompare dietro al paesaggio: un dato oggettivo concreto sancisce la fine di questo tempo.
Finisce dove un tempo finivano le giornate umane, in un crepuscolo.
Lo spettatore deve sapere che l’azione ha una durata, un termine riconoscibile e che si trova a partecipare di un atto temporale, rispetto al quale può decidere di sottrarsi, cioè andarsene…
…come del resto succede anche a teatro, che degli spettatori si alzino ed escano dalla sala.
La durata è materia dell’esperienza, della possibilità stessa di fare esperienza, che non può che avvenire nel tempo ed è materia e fulcro di questo lavoro, poiché il durare, il persistere, è la condizione per una eventuale (nel modo dell’evento) apertura percettiva, perché cioè la percezione dello spettatore abbia la possibilità di aprirsi alla consegna del presente. Questa consegna ha la forma dell’incontro, dell’affioramento, ma anche la misura di come la presa sensoriale si dispone a cogliere. L’insistere dello sguardo, degli organi di senso, di fronte all’oggetto – un’incessante pluralità – è la via semplice per un potenziale dilatarsi della trama dell’istante, della capacità di ricevere epifanicamente il presente, per un mutamento, per un riposizionamento, per un dubbio. La condizione necessaria è, dunque, restare, esporsi. Restano i corpi, nello sguardo. E se inizialmente lo sguardo va ai corpi, nello scorrere del tempo è possibile che il rapporto tra i piani cambi, che il primo piano della figura diventi sfondo, terreno per l’apparizione d’altro, che il fuoco si sposti, l’inquadratura si popoli, si apra, mostri ciò che intorno – presenze non immediatamente visibili, suoni, dinamiche, forze – agisce come divenire. È accaduto, ad esempio, che l’apparire persistente dei corpi – l’apparire (apparenza e apparizione) è la questione perché siamo nell’ambito dei fenomeni – sia divenuto remota scena per il movimento che il vento imprime ai capelli, ai fili d’erba, agli elementi leggeri, per il passaggio inarrestabile degli animali, per lo spazio, la luce. La luce manifesta. Mutando nella durata il proprio raggio d’azione, incide differentemente il visibile, dinamizza l’immagine, mostra il tempo. Scrive e riscrive lo spettatore la personale partitura di questo accadere.
Lo spettatore scrive e riscrive, tu dici, ma seguendo un percorso pensato e predeterminato: la disposizione e le diverse posture assunte dai corpi disseminati nello spazio non hanno nulla di casuale.
L’azione è studiata e concertata come pluralità. Al tempo stesso ogni corpo – assoluto – si consegna a un’oggettività auto-evidente nella solitudine, come se costituisse un mondo a sé: tra le tante possibilità innescate dall’azione c’è quella di incontrare un corpo solo.
Come puntualmente è accaduto nella prima versione del lavoro che si svolgeva su uno sperone di terra affacciato sul mare di Castiglioncello e sul golfo di Baratti, una distesa erbosa che intercettava terra, mare e cielo. Anche in questa porzione di mondo abbastanza ampia, c’è stato comunque qualcuno che si è inchiodato accanto a un solo corpo, che si è messo in ascolto di un’unica figura, senza mai staccarsi da essa.
L’idea è che non tutto sia dato nella totalità di uno sguardo, qualcosa – o qualcuno – lo incontri, di qualcos’altro hai soltanto l’indizio, il sentore. Nel momento in cui l’unità della visione teatrale è perduta, dispersa, il libero collocarsi dello spettatore in uno spazio che non può essere abbracciato nella sua interezza, l’esercizio del posizionamento, supplisce alla mancanza di totalità. Lo spettatore si trova ad adottare una propria misura, un ordine, una visione, si coglie nell’esperienza.
Torniamo per un momento sull’immobilità dei corpi. Il corpo dei performer non si muove, è immobile, anzi inerte, lo spettatore si muove tra i corpi e anche il mondo, la terra, il cielo, si muovono nel mutare della luce. Questo sembra porre dei problemi per la definizione di Body Farm… Facendo un passo indietro per rivedere sommariamente i tuoi lavori precedenti: Euforia, Abstract, Chamber Music, Body Farm, la linea che si potrebbe intravedere va dal movimento all’immobilità, dal teatro agli spazi espositivi e da questi ultimi all’aperto del paesaggio. C’è una progressione nel tuo lavoro, che di solito viene definito coreografico – Habillé d’eau con Euforia ha vinto il premio Ubu per la migliore coreografia del 2018 – che trova un esito terminale nell’immobilità?
Ti risponderei di no. Body Farm non rappresenta un esito terminale, sebbene forse lo sia per radicalità. È in realtà il primo momento di una progettualità produttiva che include Chamber Music e un ulteriore lavoro che vorrei presentare il prossimo anno. Mi sento vicina a quei pittori che per tutta la vita dipingono sempre lo stesso oggetto. Non mi sposto da alcune questioni, sempre le stesse, più che altro articolo tessiture dinamiche diverse, differenti meccanismi di presa – che corrispondono a degli sviluppi o a delle angolature dello sguardo – per provare a cogliere ogni volta lo stesso oggetto. La cattura è una questione sostanziale. Da un certo punto di vista, rifiuto il termine “coreografia”, non nel suo senso etimologico – ma è un discorso nel quale non vorrei nemmeno addentrarmi – semplicemente è altrove ciò che mi muove al corpo e alla sua scrittura, il mio è solo un appostamento. Si tratta per me di costruire ipotesi, esercizi, condizioni che possano catturare, rilevare traccia di un’immanenza. Anche Body Farm non è altro che un’azione dell’origine, nel senso che prova ad avvicinare l’origine stessa. E l’origine, dal mio punto di vista, è il corpo. Il corpo-limite, il corpo-materia che, come già dicevo, esercita una chiamata prima della parola, prima dell’azione, prima di ogni intenzionalità. È nell’assenza di intenzionalità che l’uomo appare nella sua dimensione originaria di soglia antecedente anche all’umano, in quel coincidere e non coincidere mostra un senso del sacro…
Cosa intendi per sacro?
Quel vivente universale che non ha ancora nome, non ha ancora volto e che si dà nella superficie, nel mistero della superficie. Quel volto che non è maschera, ma universalità, che riconosco come specchio. Body Farm è anche questo: un lavoro sullo specchio, sulla possibilità e il disagio del riconoscimento. Su un io-tu che precede le forme culturali. Dove la domanda scaturisce da un corpo privato dei suoi strumenti umani, inerziale, come addormentato, un corpo che dis-attende ma chiama, è ancora in grado di chiamare. Un corpo colto nell’eternità, un istante reso al tempo. E c’è dinamica in quel permanere…
Di che natura sono le apparizioni di Body Farm? Se da una parte è scontato che la mimesis sia messa in scacco e quelle immagini non siano né la copia, né la ripetizione, né l’imitazione di alcunché, dall’altra esse possono alludere a qualcosa, a qualcosa che non è mai in scena, che resta sempre fuori dalla scena, ma che sulla scena incombe…
Stiamo parlando di una possibilità di riconoscimento, un passaggio dall’ignorare al ri-conoscere, al cogliere, come attuazione di un incontro con il volto-corpo che ho di fronte, una possibilità legata al concetto di universalità di cui parlavo prima.
Sarebbe il riconoscimento di qualcosa che non ho mai visto…
È il riconoscimento di qualcosa che non ho mai visto e al tempo stesso ho sempre visto. Se accade, e non è detto che accada, è l’esperienza ineludibile di un tocco… La parola “allusione” è pregnante perché contempla uno spazio vuoto tra il dato e il suo riverbero, resta aperta tra l’immagine nel senso fenomenico e il potere generativo che esercita.
Questo è un concetto che ti è molto caro. Cerchiamo di chiarirlo: in che senso un’immagine è generativa?
L’immagine non è forma chiusa, essendo esattamente s stessa è sempre oltre sé: non coincidenza, apertura, orizzonte di possibilità, dynamis. È la messa in dinamica del dato. Federico Ferrari parla di picture acts. Il potere generativo è la capacità performativa dell’immagine di essere azione, di inaugurare dispiegare divenire, mondo. Tornando alle presenze in Body Farm, il lavoro sul corpo non contempla la copia, la riproduzione mimetica, predispone il corpo stesso ad aprirsi processualmente alla materia, a incontrarsi, a incontrare la propria dimensione generativa che ha il tratto di un esser fuori.
Jean Pierre Vernant in L’immagine e il suo doppio, a proposito dello stato della mimesis e del mimeisthai nella Grecia del V secolo, parla di un atto che, più che una rappresentazione, si pone in rapporto con lo spettatore con una “azione efficace”. Massimo Marino che su doppiozero ha recensito Body Farm, ha scritto che il lavoro ridava un senso alla parola performance…
Al di là di ogni possibile storicizzazione, la parola performance chiama in campo il carattere di accadimento. L’accadimento qui non riguarda la volontà del performer di estremizzare una situazione. Il disporsi dei corpi che configura la scena è un disporre, un fare che apre a un farsi altrove. Forse a questo si riferiva Marino: qualcosa si è messo in moto di non semplicemente riconducibile a un corpo immobile, ciò che era estraneo è diventato presente, ciò che era periferico centrale. L’aprirsi dello spettatore al tempo, non provocato da alcuna demiurgia, ha reso eventualmente possibile una riconfigurazione percettiva delle relazioni, un’irruzione del mondo, l’esperienza dell’unità, della separatezza ceduta alla molteplicità, al flusso, a un divenire inafferrabile, che tuttavia si fa volto.
A questo punto non possiamo sottacere il fatto che “l’estraneità che diventa presente” di cui parli, in Body Farm sia – cioè sia stata percepita come – quella della morte, dell’improvviso apparire di uno spiazzante regno dei morti. C’è una riflessione fatta dal filosofo Byung-Chul Han durante la pandemia che si conclude dicendo: in ogni caso la morte va restituita alla vita. L’azione di Habillé d’eau opera anche nel pensiero di questa restituzione?
La questione dell’impermanenza, della morte, è certamente un nucleo nel lavoro di Habillé d’eau, come lo è per le arti vive, dove il mio domandare cerca un campo di pratica: temporalità, fattualità fenomenica, fragilità, non riproducibilità, limite, dinamica, incontro… Per risponderti dovrei partire da una personale domanda alla vita. Fatico a parlarne, è la ragione per cui continuo a lavorare con il corpo, accanto al corpo, accanto ai corpi. È una chiamata – prima di tutto sensoriale – che non si esaurisce. Quanto è sconosciuto, sorprendente, chiamante un corpo privo di coscienza, assolutamente umano nel suo ritiro nella corporeità – corpo addormentato, corpo inerme, corpo morto, presentificazione di una trascendenza. In Body Farm, volevo darne fatto, provare concretamente a realizzare un luogo per la contemplazione, una zona di esperienza non codificata, anti-spettacolare e tuttavia pulsante. Volevo ridurre la formulazione all’origine: i corpi, lo spazio, il tempo e in assoluta apertura lasciare ogni persona alla propria chiamata, rendere attuabile in questa “visita” ciò che a me sembra l’unica via: la prossimità. Essere vicino a un corpo che si dà nel silenzio, non nella voce. Perché è nel silenzio che diventa infinito. Restituire la morte alla vita, dicevi, o la vita alla morte: volgere lo sguardo dove gli estremi trovano un luogo, un ubi consistam. Nel suo manifestarsi insufficiente il corpo salda l’origine e l’oltre.
Body Farm viene dopo i corpi occultati e sottratti ai riti di sepoltura della pandemia ed è contemporaneo della strage di Bucha, durante la guerra in Ucraina, con i suoi corpi senza vita sparsi a terra tra cui i blindati fanno lo slalom: è un’azione che riporta l’indicibile, il rimosso alla visibilità. All’inizio di un tuo scritto dello stesso periodo dedicato a Tutto brucia dei Motus e pubblicato su Quaderni d’arte italiana si legge: “Le variazioni cromatiche del buio, il campo piatto di cenere e giochi neri, la voce straziata del canto, i corpi senza riparo né riparazione,” E l’immagine, insieme mite e potente, che hai scelto per accompagnare quelle parole è il dettaglio di una fotografia scattata durante la prima fase dell’invasione russa dove non si vedono dei corpi umani, ma i cadaveri di due cavalli stesi sul ciglio della strada, circondati da una campagna spoglia che sprofonda nel gelo e nel silenzio… Immagino tu sia consapevole di questa costellazione…
Assolutamente. Body Farm è un progetto precedente al Covid e alla guerra, che si è potuto concretizzare l’anno scorso, grazie al gesto visionario di Angela Fumarola di Armunia e contro una mia iniziale resistenza. Nel frattempo, infatti, c’era stata l’invasione dell’Ucraina e la vista di quei corpi era inviolabile, non volevo che il lavoro fosse letto come una rappresentazione o un’appropriazione di tragedie e immagini reali. Solo dopo alcune prove sulla collina, con Habillé d’eau abbiamo deciso di assumere il rischio e nessun riferimento esterno diretto sembra aver sopraffatto l’immediatezza percettiva. L’immagine dei cavalli morti? L’orizzontalità dei corpi, l’indifferenza della natura… Nella pubblicazione quella fotografia apre, nella scrittura originale termina il testo, arriva dove le parole cercano lo spettro di una strada…
A Castiglioncello, come hai detto tu stessa, c’erano condizioni di visione irripetibili: la spianata che si affaccia sul mare, l’orizzonte aperto, l’orologio della performance che rispecchia e segue la rotazione della terra e del cielo, tutto alludeva a una condizione cosmica e primigenia, non alla Storia… Persino i rumori che venivano dal nucleo cittadino più vicino erano quelli, anacronistici, di una festa di paese. Il luogo di Body Farm deve sempre essere alto (e altro) rispetto al mondo? E come cambierà la sua percezione nello spostamento in centri urbani come Milano, Bologna, Roma, dove il teatro dell’azione sarà il Monte dei Cocci, questa mescolanza di naturale e di artificiale che sorge proprio al centro della città?
Il luogo è il perno. Anche in questo caso si tratta di un riconoscimento, di cogliere una possibilità trasformativa che il compito performativo attua. Il luogo esiste di per sé, nella propria autonomia, che la presenza dei corpi scopre mentre a quell’estraneità gli stessi corpi tornano. È il regno dell’estensione, del fuori, il fuori fuoco, il fuori campo, l’oltre: è dinamica lo spazio, impronta e premonizione del tempo.
La scelta del luogo, affatto semplice, deve necessariamente compromettersi con le circostanze concrete, cogliere il battito che, al di là delle forme di volta in volta prese dal lavoro, ne costituisce l’origine. A Bologna, Roma, Milano ci confronteremo con situazioni molto diverse, non sempre favorevoli, con la stessa attitudine di esperimento: metterne effettivamente in verifica la possibilità. A Roma, dell’unica esperienza realizzata nella riserva di Rosignano, proviamo a ricercare la forma circolare, con le sue spinte dinamiche e il suo sistema aperto di orbite, percettivamente e simbolicamente, mondo, pianeta, cosmo. L’azione della luce. Poi l’altezza, elemento di separatezza e al tempo stesso di congiunzione…
La montagna è un axis mundi…
Un luogo da cui puoi vedere lontano, radicato al centro e proiettato in ciò che sta intorno, riguardato dal fuori che irrompe. A Roma saremo su un’altura di 50 metri, il Monte dei Cocci, un’antica discarica romana, ricoperta nel tempo di terra e immaginazione. Una fusione di natura e artificio, come hai detto, che pur essendo visibile in piena città, mantiene l’elemento di separatezza. C’è una soglia da varcare per accedere alla sommità che solo allora svela.
Ha qualcosa di olimpico…
Ma anche di reietto, è un Olimpo impuro. Che comunque, aperto alla visione, regala gli elementi circostanti, le case, il movimento, la ferrovia…
Anche qui, insomma, c’è un paesaggio che sorge…
Sì e mi aspetto che ci sia una luce che investe, che bagna i corpi e le cose, chiaramente percepibile nella sua facoltà di riscrivere il reale.
In Body Farm, tu hai lavorato su coloro che, diceva Ungaretti, “hanno l’impercettibile sussurro.” Posso chiederti, giunti alla fine di questa conversazione, come hai lavorato con i performer sul sussurro, cioè sulla respirazione rispetto allo stato di inermità, di disarmo, in cui si presentano i loro corpi?
(A questo punto, alla domanda sulla respirazione, la registrazione misteriosamente si interrompe, la risposta, come direbbe Dylan, si perde nel vento, premendo il tasto play di udibile restano soltanto venti, lunghissimi, minuti di silenzio)
Roma, 24 agosto 2023
Habillé d’eau è un progetto di ricerca performativa indipendente, fondato nel 2002 da Silvia Rampelli, focalizza la riflessione sulla natura dell’atto, sulla centralità della dimensione percettiva nella pratica scenica, nei processi esperienziali trasformativi. Ne sono parte: Alessandra Cristiani, Eleonora Chiocchini e, nel tempo, Francesca Proia, Gianni Staropoli, Valerio Sirna. Habillé d’eau è stato prodotto da La Biennale di Venezia e invitato nei maggiori festival. Numerosi sono i testi critici pubblicati e i riconoscimenti. Nel 2018 riceve il Premio Ubu per il Migliore spettacolo di danza.
Attilio Scarpellini è saggista, critico di teatro e dramaturg. Conduce la trasmissione di Radio Rai 3 “Qui Comincia“. Ha fondato e diretto fino alla chiusura i Quaderni del teatro di Roma. Ha scritto L’angelo rovesciato. Quattro saggi sull’11 settembre e la scomparsa della realtà (Roma, 2008), La fortezza vuota. Discorso sulla perdita di senso del teatro (con Massimiliano Civica, Roma 2014) e Il tempo sospeso delle immagini (Milano, 2020).
COMBIN/AZIONI è la sezione di CUT/ANALOGUE delle conversazioni, spazio per un materiale che si attiva in una reciproca implicazione. Campo di possibilità discorsive che si generano come mescolanze dinamiche tra soggetti, situate in un tempo, contingenti.