19 agosto 2020
Questa conversazione, a cura di Simone Frangi, nasce in occasione di una delle attività previste da More Than This, progetto europeo di cui Short Theatre è partner dal 2018, e che quest’anno volge a termine: il Displacement of Festivals. Parte di questa edizione del festival è frutto della collaborazione – e coabitazione – con un secondo festival, Materiais Diversos di Minde, Portogallo. Un festival estero, anch’esso partner del progetto, che si “disloca” a Roma per aprire nell’accadere di Short Theatre una finestra, uno spazio, una temperatura diversa, che non sarà né quella propria, né quella del festival ospite. Prefigurare questa temperatura è stato il lavoro che i due staff del festival hanno condotto in questi mesi, che avrebbero dovuto vedere diverse fasi di collaborazione in presenza, e che l’emergenza sanitaria ha inevitabilmente reso differenti, fecondi in un modo forse inaspettato: la riflessione sui concetti di ospitalità, identità, diversità e mobilità si è fatta ancora profonda, urgente, radicale, immaginativa.
A prendere parola: Simone Frangi, curatore e ricercatore, Daniel Blanga Gubbay, co-direttore del Kunstenfestivaldesart – Bruxelles, Elisabate Paiva, direttrice artistica di Materiais Diversos – Minde, Francesca Corona, co-direttrice di Short Theatre.
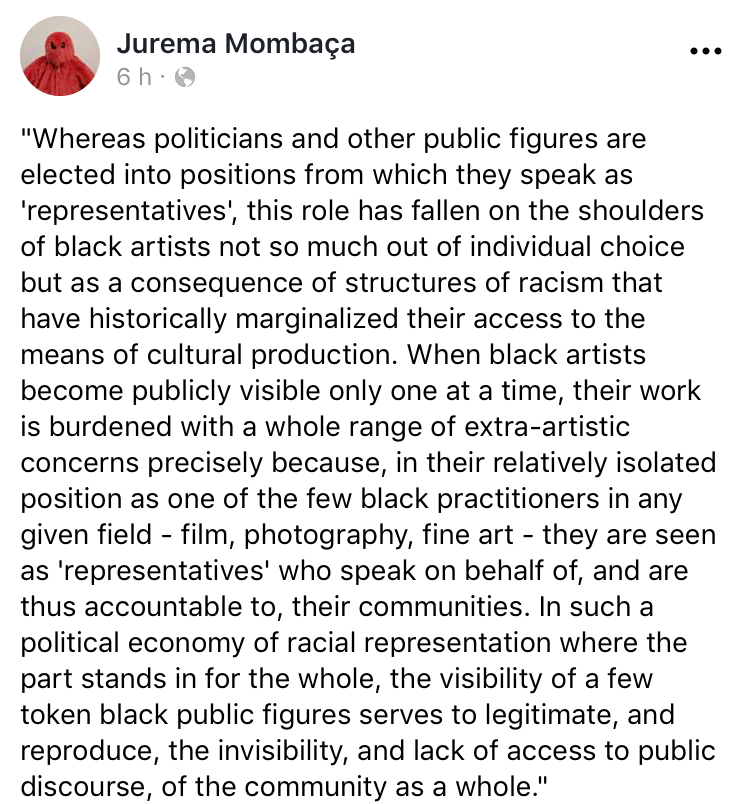
Daniel Blanga Gubbay: Disconnettere la nozione di “ospitalità” da quella di “territorio”, ha importanza, secondo me, anche rispetto alle riflessioni di JuremaMombaça qui e in altri contesti.
La nozione di ospitalità ha la tendenza a ricalcarsi sempre nella pratica cartografica, nel marcare un territorio che appartiene all’host e in cui il guest è invitato, “accettato”, una decisione che implica sempre la possibilità del suo contrario.
Una delle questioni che più mi ha interessato nello sviluppo e nella scrittura del progetto More ThanThis e delle riflessioni che abbiamo fatto intorno alle pratiche curatoriali è la maniera in cui la dicotomia tra host e guest possa complessificarsi al di là degli spazi territoriali definiti. In che modo potersi pensare continuamente, simultaneamente ospitanti e ospitati, host and guest?
È un aspetto strutturalmente pregnante se pensiamo al festival, non soltanto in un progetto come More ThanThis che si basa sull’idea di displacement. Storicamente i festival si sono sempre pensati come una pratica di accoglienza di artist_, di pubblico, di altre pratiche. In che maniera, invece, il festival si deve pensare accolto all’interno di quelle pratiche o accolto all’interno di un territorio che non gli è proprio?
Simone Frangi: rispetto alla nozione di inclusività come ti posizioneresti? Effettivamente è il nucleo più critico della posizione di JuremaMombaça.
D.B.G.: la nozione di inclusività ha il suo limite politico nel fatto di avere un dentro e un fuori che è predeterminato rispetto alla performatività politica. Esiste un limite imposto a priori e un’accettazione politica – il termine “accettazione” è volutamente problematico in questo campo – di poter includere qualcosa o qualcun_ all’interno di questo territorio predeterminato: questo ricalca una modalità coloniale di occupazione del territorio e definisce quelle che sono le regole e le persone che hanno diritto di entrare in quel territorio. L’inclusività, per come è marcata nel contesto occidentale, viene presentata come un’eccezione a quella regola, sottolineando il fatto che ogni territorio ha delle sue regole non scritte, le quali prevedono che qualcuno possa sì essere incluso, ma che non ne fa naturalmente parte. La questione è quindi il poter immaginare una forma di territorio che non sia definito in regole normative o naturalizzanti, ma che si possa fondare sulla possibilità e l’uguale diritto di coloro che abitano quel territorio, anche in maniera temporanea.
Simone Frangi: chiederei a Elisabete e Francesca come secondo loro questa provocazione di ordine politico possa tradursi in termini curatoriali. Come scardinare la nozione binaria di ospitalità applicata alle pratiche degli/lleartist_ e ai formati? Come attivare pratiche che, in termini di programmazione di un festival, possano scardinare determinate regole curatoriali e decisionali?
Elisabete Paiva: mentreparlavate stavo pensando all’importanza di poter immaginare un festival fuori dal suo territorio naturale. MateriaisDiversos è visto come un festival prevalentemente legato al suo territorio, e all’identità specifica della sua comunità. Io, al contrario di chi dirigeva il festival all’inizio, non provengo da quel territorio quindi sin da subito le questioni si sono mescolate e complessificate. Durante il periodo di dialogo per la preparazione del Displacement a Short Theatre ci siamo rese conto che non stavamo entrando in relazione con la soggettività di un festival o di un territorio, ma con la totalità delle soggettività che lo compongono. Credo che l’introduzione dell’individuo, del dialogo tra persona e persona, tra collettivo e collettivo e non il dialogo tra territorio e territorio, aggiunga uno strato ulteriore a questa questione che può essere produttiva.
In questo processo ci confrontiamo anche con la possibile semplificazione dei territori nei quali emergono i nostri festival, siamo invece in dialogo come gruppi di persone che dirigono e sviluppano festival in e con quei territori, senza volerli rappresentare.
Francesca Corona: stavo riflettendo sulla relazione tra territorio e ospitalità. In qualche modo il Displacement messo in atto per More ThanThis, arriva oggi con un sistema di pratiche molto diverse da quelle che avevamo immaginato, aggiungendo un altro scarto nella relazione tra territorio e ospitalità. L’impossibilità di ospitare fisicamente MateriaisDiversos nella preparazione, il fatto di non poter coabitare negli stessi spazi mentre immaginavamo questo Displacement, ha evidenziato in modo più radicale la relazione non tanto tra ospitalità e territorio, piuttosto tra ospitalità e pratiche, includendo in esse anche le modalità d’invito dell’altro. Fare ulteriormente spazio a un festival, quindi a “qualcuno” che è abituato a invitare e a ospitare l’altro ha permesso una specie di allenamento a questa disgiunzione tra territorio e ospitalità. Sì, è stato un vero allenamento, forse più atletico di quello che pensavo, anche rispetto alle reali possibilità di mobilità nelle quali ci troviamo a operare ora.
E.P: sono completamente d’accordo. È stato frustrante non poter arrivare a Roma e stare più tempo con il gruppo di lavoro, eravamo molto consapevoli che la modalità di lavoro di Short Theatre implicasse leggere insieme, camminare insieme, mangiare insieme e, nel mentre, pensare al Displacement. Il fatto di aver dovuto risolvere tutto attraverso riunioni Zoom ci ha richiesto un altro tipo di esercizio che non ci aspettavamo di dover fare. È allo stesso tempo atletico, come diceva Francesca, e ridotto, ci si sente forzati a un esercizio di sintesi, che sembra semplificare qualcosa che non è per nulla semplice.
Ad esempio, mentre Francesca parlava, stavo pensando a come tutti_ percepiscano un festival come una mappa definitiva, un prodotto finito che rappresenta un discorso, una visione, un territorio, mentre credo sia solo una piccola parte che emerge di un intero processo di pensiero e di lavoro, che in realtà non è mai davvero finito, concluso.
Quello che ho sentito con il Displacement a Roma è che alcune scelte siano state anche il risultato di una serie di fattori contingenti: il lavoro davvero atipico di questi mesi, il fatto che non siamo riusciti a stare insieme, ma, anche, il fatto che abbiamo desiderato davvero che alcun_ di quest_ artist_ viaggiassero con noi.
D.B.G.: vorrei aggiungere una parola al lessico immaginario che emerge dal progetto di More ThanThis, che era stato scritto due anni fa attraverso una serie di parole chiave: hospitality, complexity, displacement e anche rispetto al desiderio di rompere questa idea di rigidità della territorialità di chi è ospitat_ e chi ospita. Una parola si aggiunge in questo momento storico, ed è quella di contagio. Le pratiche di ospitalità hanno in sé una potenzialità di contagio, di contaminazione, rispetto all’uso – e all’abbandono – di pratiche definite. In che modo è possibile, in questo anno così particolare, rivalutare la possibilità di contaminazione che esiste in queste pratiche, qualcosa che sposta continuamente, in maniera impercettibile o percettibile ma, soprattutto, imprevedibile, l’asse di ciò che contaminiamo, venendo a nostra volta contaminati dalla pratica dell’altr_. Per me il Displacement può essere visto oggi attraverso la lente della contaminazione, ovvero di ciò che resta iscritto nel DNA una volta che questo incontro è avvenuto.
S.F.: per reagire a quello che ha appena detto Daniel mi soffermerei anche sulla nozione di complessità, che questa idea di contaminazione mette in crisi.
Siamo abituati a pensare la complessità in termini additivi, mentre la vera sfida a cui siamo di fronte adesso è tentare di trovare una nuova narrativa per questa nozione. La seconda provocazione teorica, ma anche estremamente pratica, che mi sembra utile lanciare è quella di pensare la nozione di complessità tentando di rimettere in discussione anche quella di diversità: è possibile rinunciarvi? Sara Ahmed in On Being Included: Racism and Diversity in Institutional Life, in maniera estremamente critica affronta la retorica della diversità da un punto di vista istituzionale. Spesso soggettività artistico-politiche che sono state considerate straniere rispetto a un territorio che, come diceva Daniel, è estremamente definito sono di fatto impossibilitate a entrarvi. Vengono quindi inserite in narrative istituzionali per dimostrare che l’istituzione stessa non ha problemi con il razzismo, con il sessismo, con la complessità e la diversità. In realtà, sostiene Sara Ahmed, per queste soggettività è un lavoro emozionale molto duro perché, oltre a essere othered, considerate altre, quando vengono incluse all’interno dell’istituzione viene chiesto loro di fare un lavoro di critica severa nei confronti dell’istituzione stessa. C’è quindi una forma di secondo sfruttamento dal punto di vista istituzionale.
Da un punto di vista organizzativo, curatoriale, di organizzazione e creazione di spazi, come si può lavorare all’altezza della complessità senza sfruttarne la retorica, proprio in una dimensione più fluida, pensando a interazione mutue e anche di messa in pericolo di alcuni spazi istituzionali così come sono stati creati? Penso proprio nell’ottica di programmazione di un festival, della programmazione di un’istituzione, anche nell’apertura verso determinati pubblici che spesso non hanno codici, che non arrivano con tante chiavi di lettura dei lavori e che possono anche effettivamente mettere a rischio la validità di alcune proposte artistiche o curatoriali.
D.B.G.: in questa domanda ci sono due aspetti che mi interessano molto. C’è il sapere che nel momento in cui organizziamo un festival quello che stiamo curando non è semplicemente quello che stiamo guardando ma come lo stiamo guardando. La performing art ha la possibilità di iscriversi in una storia di allenamento dello sguardo, ma si ritrova in ogni caso all’interno di una storia coloniale e deve quindi fare i conti con cosa significa guardare un altro corpo, guardare un’altra pratica, cosa significa poterlo fare in una modalità che metta in discussione non tanto il corpo che si sta guardando ma lo sguardo che lo guarda, e riconoscere che quello sguardo è iscritto in una griglia che ha un suo portato storico e politico nella storia della visione in Occidente. Questo mi viene in mente rispetto a quello che propone Sara Ahmed, ovvero di capire in che maniera questo discorso politico stesso possa intaccare la storia dell’istituzione e non soltanto il suo contenuto. Ci sono molte riflessioni che stanno emergendo in questo momento, mentre parlavi mi veniva in mente una frase molto famosa di Su’ad Abdul Khabeer, che dice: “Youdon’thave to be a voice for the voiceless. Just pass the mic” (Non c’è bisogno tu sia la voce di chi non ha voce. Semplicemente, passa il microfono). Pensare che, anche la pratica curatoriale, non debba sempre iscriversi nell’idea di dare la possibilità a qualcuno di parlare ma capire quali sono gli strumenti strutturali per poter “passare il microfono”, e potersi iscrivere in quel gesto non di accoglienza o di spazio determinato in un vero gesto di empowerment dell’altro o dell’altra.
E.P: nella nostra pratica quello che cerchiamo di fare è dare più spazio possibile, anche nel processo curatoriale, a ogni artista che invitiamo. Ed è stato generoso ora da parte di Short Theatre lasciarci lo spazio per continuare quello stesso nostro dialogo con gli/le artist_. In quello che è stato detto, mi tocca in maniera particolare la nozione di complessità, che solitamente associamo all’idea di sommare, e adesso invece ha molto a che vedere con il dover togliere.È molto complessa la maniera in cui si deve agire con la mancanza di così tante cose.
F.C.: prima si citava Sara Ahmed e di come l’invitare e il presentare il lavoro di minoranze all’interno di alcune istituzioni possa agire, in parte, vampirizzandole. Credo che questa sia la questione in questo momento, credo sia il rischio più vicino, almeno quello che sento più vicino alle nostre – parlo di nostre perché mi sento di includere tutta una generazione di festival, di curatori e curatrici, di teste, di pensieri, di emotività. Ci siamo riferite a questo Displacement come allenamento, ma possiamo parlare anche di un disallenamento dello sguardo, nell’imparare a non sottovalutare questo rischio e attivare delle pratiche di sottrazione di strati che sono nei nostri occhi. Quanto possiamo fidarci del nostro sguardo?
S.F.: mi sembra che il Displacement fosse proprio lo strumento che More ThanThisha creato per mettere in atto processi da una parte di decolonizzazione rispetto anche a delle nostre posture, se vuoi nazionali e disciplinari e, dall’altro, uno strumento per aprire nuove vie di collaborazione, che non fossero semplicemente lo scambio di competenze, ma l’idea di creare zone di rischio per le diverse istituzioni coinvolte all’interno del progetto. Avevo identificato una citazione che mi è molto cara, una teoria di Susan Leigh Star, sociologa della scienza, che parla di come noi dal punto di vista dello spazio immaginiamo la nostra vita, le nostre attività, i nostri formati. Think of space as an arrangement of priorities: Things that are more important are closer to the center; things less important are farther away. The center is always defined with respect to a set of questions. […] How are formal (mathematical, computational, abstract) representations defining the space of our world? What are the moral consequences of using formal representations?
(Pensate allo spazio come a un’articolazione di priorità: Le cose più importanti sono più vicine al centro, quelle meno importanti sono più lontane. Il centro si definisce sempre rispetto a una serie di domande. […] Come le rappresentazioni formali (matematiche, computazionali, astratte) definiscono lo spazio del nostro mondo? Quali sono le conseguenze morali nell’usare queste rappresentazioni formali?) [Ecologies of Knowledge: Work and Politics in Science and Technology, a cura di Susan Leigh Star]
Le mappature sono sempre frutto di una sorta di regole accettate dalla comunità. Come questo strumento spaziale che è il Displacement rivoluziona completamente le regole dell’accettazione comunitaria? Che cosa ci insegna il Displacement?
Oggetti culturali emersi in un determinato spazio comunitario, nel momento in cui vengono spostati in un altro spazio, assumono significati completamente diversi e mettono a rischio sia le pratiche artistiche, che le istituzioni, ma, anche, i concetti che ci sono dietro. La mia domanda ruota proprio intorno all’efficacia del Displacement come strumento pedagogico. Da punto di vista istituzionale, vi è sembrato abbia modificato qualcosa?
F.C.: in questo momento, mentre parliamo, il Displacement che abbiamo costruito insieme deve ancora avvenire, o, almeno, è avvenuto nella sua immaginazione, ma manca quel guardarlo accadere. Ma già nella sua preparazione la questione della desoggettivizzazione è il primo meccanismo evidente. Nel momento in cui si fa veramente un passo laterale rispetto al territorio e alla comunità che si vuole costruire, o che si pensa di aver costruito, si deve rinunciare all’idea del curatore o curatrice come qualcun_ che tiene le fila di tutto, che immagina tutto quello che deve avvenire, tutto quello che accade. All’interno del Displacement c’è radicalmente, fin dall’inizio, la negazione di tutto questo. Non è un lavoro di co-curatela o di invito a un_ curatore o curatrice, è un altro tipo di pratica: è mettersi da un lato e guardare accadere, una pratica a cui siamo abituati nel momento in cui festival si fa, non nel momento in cui il festival si immagina.
In apertura di Short Theatre 2020 quest’anno c’è una lectio/assemblea di Elsa Dorlin. Capire cosa significa situare il discorso di Elsa Dorlin nella piazza davanti all’Ex Gil, è fondamentale per osservare la differenza tra territorializzare il discorso e situarlo. Sono due cose molto diverse, che non vanno confuse e lo dico anche a me stessa. Rispetto alla responsabilità pedagogica che abbiamo in quanto istituzioni, trovarsi a lavorare, in modo chiaro e definito, sulla questione del “situare”, sottraendosi ad ogni prospettiva antropologica.
S.F.: è molto interessante mettere in opposizione l’idea della prospettiva antropologica con l’idea della prospettiva pedagogica. La pedagogia implica in un processo critico anche coloro che portano le istanze dell’educazione, quindi le istituzioni stesse; mentre l’antropologia, storicamente fa astrazione dei soggetti che si pongono le domande. Credo sia molto importante quello che dici anche nell’ottica di una pedagogia espansa, una pedagogia delle istituzioni, una pedagogia dei monumenti, un processo di reale complessità.
E.P.: quello che sento nel nostro caso è che abbiamo dovuto delegare a Short Theatre questa parte del lavoro di cui di solito ci prendiamo cura nel dettaglio. Non sappiamo veramente nulla del pubblico romano, pensiamo possa essere non solo locale, perché Roma a differenza di Minde è una capitale, pensiamo ci possano essere delle minoranze, molt_ artist_, ma in realtà non lo sappiamo. Abbiamo lasciato la questione del pubblico e dello sguardo pedagogico nelle mani di questo gruppo di lavoro. È stato un esercizio un po’ strano. C’è una questione in particolare che vorrei sottolineare: non avevamo pianificato di viaggiare con quattro artist_ portoghesi. È qualcosa che è successo a giugno, durante il processo di costruzione del Displacement ed è stato strano rendersi conto che eravamo un festival portoghese che avrebbe portato tre artist_ dal Portogallo e uno dal Brasile. Come ha detto Francesca, non sappiamo che cosa accadrà e ne sono molto consapevole, il Displacement è in corso e sapremo solo alla fine del Festival che cosa avrà voluto dire per i team, il pubblico, gli/le artist_ e per i Festival stessi. Sono molto curiosa di capire che cosa succederà agli/lleartist_, che non sono assolutamente contestualizzat_ come “gli/le artist- della rassegna portoghese a Roma”. Affrontano la questione del luogo in modi diversi ed è questo che lega questi quattro lavori insieme, tutti affrontano il nodo dell’essere in un posto, di essere in una certa posizione, e ognuno a suo modo è distante da una presunta “questione portoghese”.
Aggiungerei qualcosa sulla complessità che si lega all’idea di curatela che sia io che Francesca abbiamo evidenziato. Un festival non è qualcosa di finito. È un punto lungo un percorso. È un esercizio, un flusso di pensiero e non può essere imprigionato in un prodotto. È la creazione di una comunità che è costantemente in costruzione, che non afferma solo un’identità, ma che cresce insieme, in costante trasformazione.






