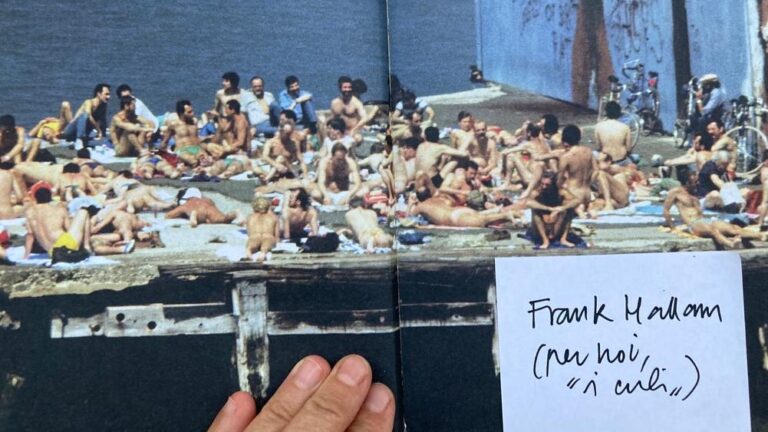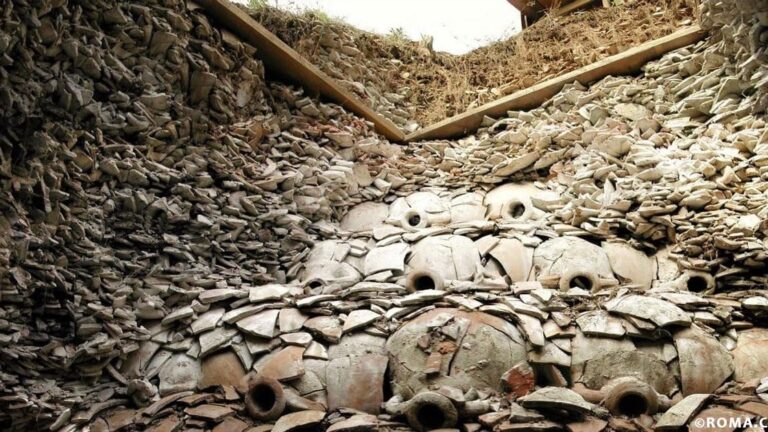di Saidiya Hartman
traduzione di Valeria Gennari
Un estratto da Perdi la madre(1) di Saidya Hartman, opera impossibile da imbrigliare in una categoria letteraria. A cavallo tra scrittura accademica, mémoire, autobiografia e romanzo, inventa un terzo spazio: la fabulazione critica. Alimentata dal motore della lacuna, Hartman si reca dove i documenti, le voci, le storie cessano di parlare. In Ghana inizia il viaggio per ricostruire la propria discendenza dagli schiavi della tratta atlantica, agendo una tensione continua verso lo scarto. Lo scarto è per lei il residuo di tutte le vite dissolte nell’amnesia, nell’impossibilità di ri-comporre memorie familiari e collettive. “Ma come si fa a scrivere una storia sull’incontro col niente?”: è la domanda di Hartman. La risposta è nei tentativi di prossimità, nella fiction che re-immagina cosa e come sono, forse, state quelle esistenze senza nome. Il libro sarà il punto di partenza per uno degli spazi discorsivi, Saidiya Hartman: parentele oceaniche e fabulazione critica, di Anticipation of the Night, che vede Annalisa Sacchi dialogare con Kwanza Musi Dos Santo e Adil Mauro.

Si dice che a osservare il mare abbastanza a lungo le scene del passato tornino in vita. Si dice che «il mare è storia». E che «il mare non ha nient’altro da offrire se non una tomba ben scavata». Guardando l’Atlantico, ripensavo alla ragazza. Ce n’erano innumerevoli altre sepolte in fondo all’oceano, ma era lei che aveva catturato il mio sguardo. Se mi concentravo abbastanza intensamente potevo rivedere tutto l’accaduto.
Il rigonfiamento della vela della nave fremeva nell’impeto dell’aria, e la tela ostruiva il cielo. Poteva essere stata l’alba, mezzogiorno o il crepuscolo. Il tempo si era fermato. La Recovery era un mondo a parte. Tre marinai, il capitano e la ragazza erano gli unici a essere visibili sulla nave. Non c’è accordo su quello che accadde dopo tranne, naturalmente, sul fatto che la ragazza morì.
Tutto il resto dipende dal modo in cui si guardano le cose o dal punto in cui ci si trovava quando il suo corpo venne appeso all’albero della nave schiavista. Nessuno vide la stessa ragazza: per ognuno di quelli che avevano osato guardare, si presentava sotto una veste diversa. Appariva come una vergine torturata, una donna incinta, una puttanella sifilitica e un bocciolo di santa. E non meno fantasiosa era la spiegazione di come fosse arrivata a stare sospesa in aria, ad agitarsi come uno stendardo lacero: la ragazza si era rifiutata di danzare nuda sul ponte con il capitano.
La ragazza aveva respinto il capitano e rifiutato il suo letto. La ragazza aveva il gran vaiolo e il capitano la frustava per guarirla dalla malattia venerea.
Il capitano, il chirurgo, l’abolizionista, tutti dissentivano su quanto era accaduto sul ponte della Recovery, eppure tutti insistevano col dire di aver cercato di salvare la vita della giovane. Su questo, sono colpevole tanto quanto gli altri. Anch’io stavo cercando di salvarla, non dalla morte o dalla malattia o da un tiranno, ma dall’oblio. Tuttavia, non sono sicura che sia possibile recuperare un’esistenza da una manciata di parole: il presunto omicidio di una ragazza negra. La sua è una vita impossibile da ricostruire, non era sopravvissuto nemmeno il suo nome.
Immagino che avrei potuto chiamarla Phibba o Theresa o Sally o Belinda. Forse con un nome sarebbe stato più difficile dimenticarla. Un nome avrebbe offerto l’illusione di conoscerla e reso meno doloroso il fatto che la ragazza «mai avrà un’esistenza al di fuori del domicilio precario delle parole» che permisero che venisse uccisa.
Poche righe dell’ammuffita trascrizione di un processo costituiscono l’intera storia della vita di una ragazza. Se non fosse stato per loro, si sarebbe estinta senza lasciare traccia. Queste parole sono l’unica difesa della sua esistenza, l’unica barriera contro la sua scomparsa; e queste parole la uccisero una seconda volta e la consegnarono ai fondali dell’Atlantico.
Dei ventuno schiavi che morirono a bordo della Recovery, e del milione e più di quelli gettati nell’Atlantico, una ragazza si impone alla vista. Circostanze eccezionali le impedirono di svanire semplicemente nel cumulo di vite oscure sparse in fondo all’oceano: un capitano era stato processato per il suo assassinio.
La Commissione per l’abolizione della tratta degli schiavi portò per prima il caso all’attenzione dell’opinione pubblica. Il 2 aprile 1792 William Wilberforce immortalò la giovane in un discorso di fronte alla Camera dei Comuni e il mondo le prestò attenzione, almeno per qualche giorno. Quando il processo finì, cessò pure ogni interesse nei confronti della ragazza. Nessuno ha pensato a lei negli ultimi due secoli, ma la sua vita getta ancora un’ombra.
Il capitano le legò il polso a un paranco che fissò all’albero di mezzana, e sospese la ragazza nuda sopra il ponte. La sua pelle era ricoperta di pustole, le costole sporgevano dal suo esile busto e una delle gambe era sformata. Il capitano teneva il paranco e uno dei mozzi le tirava e le scuoteva gli arti mentre il suo corpo era sospeso in aria. La ragazza oscillò per cinque minuti prima che il capitano rilasciasse il paranco e la facesse cadere sul ponte. Poi il capitano la issò per l’altro polso. Guardò il corpo di lei contorcersi per poi lasciarla andare di nuovo. La fece ciondolare per la gamba destra, quindi ripeté il rituale con la sinistra. La gravità le aveva svuotato del sangue la parte superiore del corpo. Le estremità degli arti divennero grigie, poi blu per la mancanza di ossigeno. La pressione della corda le disegnò cerchi di sangue attorno ai polsi e alle caviglie facendole gonfiare gli arti. Il colore sul suo viso si prosciugò.
Le sue interiora cedettero. Il polso e la caviglia si lussarono a causa del peso del corpo da mantenere.
Il capitano allora le legò il paranco attorno a entrambi i polsi e la tirò su per aria. Allungò il braccio per prendere la frusta e colpì la ragazza sulla schiena, sulle natiche, dietro le ginocchia, poi la squarciò frustandole da parte a parte le braccia, le costole, i lati dell’addome, i fianchi, e poi ancora il petto, il busto, la parte anteriore delle gambe. Il suo corpo si torceva e roteava mentre la pelle grezza della frusta la colpiva. La frusta le strappava la pelle e gliela bruciava, ricoprendola di pomfi.
Il capitano lasciò andare la corda e la ragazza si schiantò sul ponte. Non si mosse. Respirava ancora, ma non si muoveva. Era svenuta sul ponte, con la testa che le penzolava sulle ginocchia. Il capitano le sollevò la testa, la schiaffeggiò e disse: «La puttana è imbronciata».
Guardando la ragazza trascinarsi su mani e ginocchia verso la stiva della nave, il terzo ufficiale chiese al capitano se dovesse aiutarla a scendere. Il capitano la insultò di nuovo e affermò: «Può farcela da sola».
La ragazza strisciò nel boccaporto e ruzzolò giù dalle scale. Il chirurgo di bordo la recuperò dalla stiva il giorno seguente. Se l’era fatta addosso, così la lavò e cercò di rianimarla strofinandole dell’alcol sulle tempie, sul naso e sulla schiena. Le mise in bocca un cucchiaio con dell’acqua ma non ingoiava. Per tre giorni rifiutò ogni tipo di nutrimento. Mentre giaceva sul ponte della nave, si scuoteva per le convulsioni. Dal suo corpo fuoriuscivano dei liquidi che formavano una pozza sotto di lei. Le ferite aperte e la puzza di decomposizione attrassero gli insetti. Quando un marinaio scoprì che era morta lo notificò al capitano e poi la gettò in mare.
[…]
La ragazza era malata sin dal momento in cui aveva messo piede sulla Recovery. Si trattava di gonorrea, il chirurgo ne era certo. La chiamavano gran vaiolo. Se ne era accorto qualche giorno dopo il suo arrivo a bordo. Piaghe infette le ricoprivano la pelle, delle perdite le scorrevano giù dalle gambe e stava scomparendo nella sua stessa carne. Di certo non era dissenteria, o «flusso sanguinoso», che nei casi gravi ricopriva il ponte di sangue e muco in quantità tale da farlo somigliare a un mattatoio. Lo scompenso venereo era comune tra i neri, il che non era una sorpresa. L’altra morta, Venere, era così che l’equipaggio la chiamava, anche lei ce l’aveva. No, la ragazza non era morta a causa della malattia. Le sue erano semplici perdite, motivo per il quale non le aveva dato del mercurio. Salasso, purga, iniezioni, medicamento di salnitro (nitrato di potassio) e gomma arabica – aveva usato tutti gli accorgimenti in suo potere. Era il suo primo viaggio da chirurgo su un’imbarcazione schiavista e non intendeva tornare a mettere piede su una nave simile.
La malattia era rimasta stabile, anche se la ragazza non era in grado di mangiare come gli altri schiavi né di partecipare ai loro intrattenimenti. Se il chirurgo non fosse stato interrotto così spesso dal capitano nel suo trattamento – dal capitano che la picchiava – la ragazza sarebbe guarita. Non era stata la gonorrea a ucciderla, ma il capitano. Era morta in seguito alle frustate. Se così non fosse stato, sarebbe finita al mercato.
Nessuno degli altri marinai, a parte il chirurgo stesso e il terzo ufficiale e i due ragazzi che assistevano il capitano parlò mai di ciò che accadde alla ragazza. Queste cose erano all’ordine del giorno a bordo di una nave schiavista. Lo sapevano tutti che l’omicidio faceva parte del «lavoro in mare». «Oltraggi di quella natura erano così comuni a bordo delle navi di schiavi che venivano considerati con la stessa indifferenza di qualsiasi altro evento insignificante; la loro frequenza li aveva resi familiari».
Il chirurgo si riferiva alle frustate, ma pure prendere le donne era una consuetudine. Era una cosa risaputa. Qualsiasi uomo di mare vi direbbe: «Ai marinai era consentito avere rapporti sessuali con le donne nere sulle quali riuscivano a imporsi. Con le schiave, agli ufficiali era permesso di concedersi ogni passione a piacimento, colpevoli a volte di eccessi così brutali, secondo la sciagurata natura umana». Quando le ragazze salivano a bordo, i marinai decidevano quali avrebbero preso per sé. «La preda veniva immediatamente spartita, e tenuta da parte fino al momento giusto. Lì la resistenza o il rifiuto sarebbero stati del tutto vani».
Nel diario che aveva consegnato alla dogana di Grenada il chirurgo non aveva fatto menzione della ragazza né delle altre, perché aveva paura. Quello era un registro di soli bianchi. Non avrebbe giurato sul libro dei morti, il diario dei neri che morivano a bordo. C’erano state così tante morti tra gli schiavi e così tante crudeltà commesse dal capitano che il chirurgo non avrebbe potuto giurare sul libro dei morti. Fece finta di baciare la Bibbia e borbottò un giuramento, ma era il suo pollice che aveva baciato, non il libro. Un resoconto veritiero sarebbe stato sgradito al capitano e pericoloso per sé stesso.
Il capitano lo aveva messo in catene, gli aveva sottratto metà della paga e lo aveva privato di due schiavi, ma questo non aveva nulla a che fare con la sua deposizione. Non aveva mai detto a nessuno di voler rovinare il capitano Kimber. Era falso quant’era vero Iddio. «Vendetta» era una parola che non gli era mai passata sulle labbra. Gli erano stati promessi due schiavi ed era semplicemente giusto che li ottenesse. […]
NOTE
(1) S. Hartman, Perdi la madre. Un viaggio lungo la rotta atlantica degli schiavi, trad. it. V. Gennari, Tamu, Napoli 2021, pp. 171-178.
Saidiya Hartman insegna letteratura africana americana e storia culturale alla Columbia University, ed è autrice di Scenes of Subjection: Terror, Slavery, and Self-Making in Nineteenth Century America (1997) e Wayward Lives, Beautiful Experiments (2019). Nelle sue opere intreccia una meticolosa ricerca storica a una narrazione che recupera dall’oblio le storie di personaggi senza nome – le prigioniere sulle navi schiaviste, gli abitanti dei ghetti di New York e Philadelphia agli inizi del ventesimo secolo. Il suo lavoro mira a far riemergere «la testimonianza di vite, traumi e fugaci momenti di bellezza che gli archivi storici hanno omesso o occultato». Con questa motivazione nel 2019 ha ricevuto il prestigioso premio MacArthur.
ECOTONI è la sezione di CUT/ANALOGUE che apre agli immaginari provenienti da altri mondi concettuali, discorsivi, materiali, in “forma di estratto”. Funge da transizione tra ecosistemi adiacenti suggerendo spostamenti graduali, nella tensione oscillatoria dell’in-tra.
photo courtesy the John D. & Catherine T. MacArthur Foundation