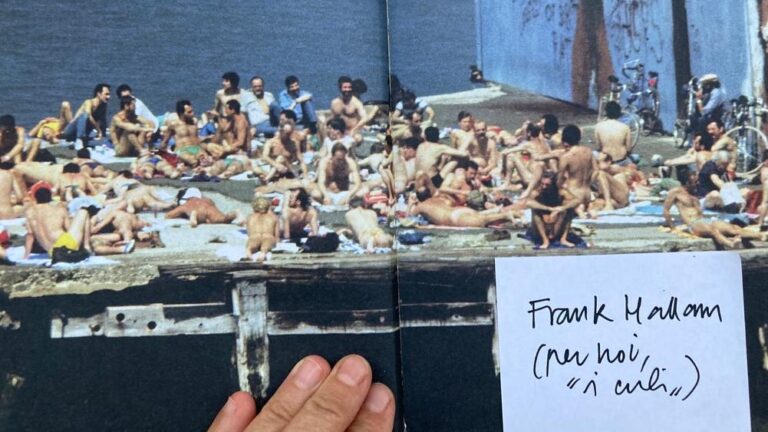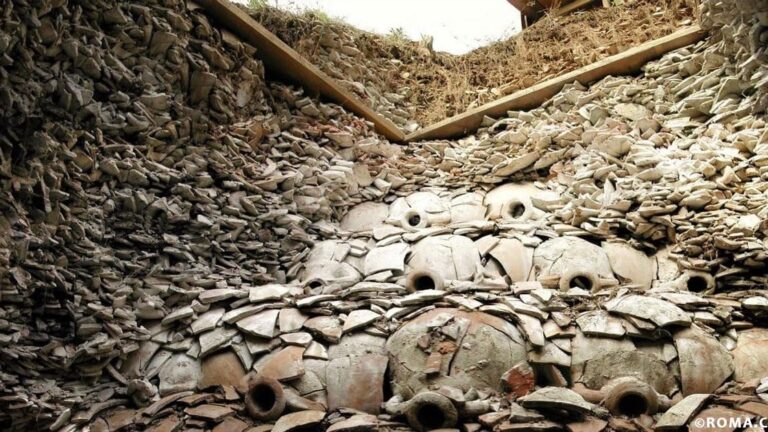CRAAAZI / Elia A.G. Arfini, Beatrice Busi, Alina Dambrosio Clementelli, Antonia Anna Ferrante e Goffredo Polizzi
Quando per la prima volta abbiamo sentito parlare del fallimento come un’arte, eravamo già fallite. Mentre il «senso comune» eteronormativo si aggrappava disperatamente all’equivalenza del successo con il progresso, l’accumulazione e la famiglia, la condotta morale e la speranza, mentre l’idea del fallimento dilagava diventando un’ossessione sociale diffusa con la crisi globale finanziaria (e poi economica, fiscale, politica) del 2007-2008, ci siamo improvvisamente sentite a nostro agio, meglio equipaggiate, più adatte. Già da prima, già da sempre, eravamo improduttive, no future, indebitate, senza famiglia, asociali, indecenti.
Nell’austerity del genere e della sessualità che regge l’economia eterosessuale, noi, la «cosa queer», eravamo, da prima e da sempre, già ladre. Praticavamo ontologicamente e incarnavamo già l’immanenza del fallimento dei modelli binari di genere e sessuali, sperimentandone le tante potenzialità, oltre alle difficoltà che a esso si associano, e che Halberstam pone alla base di un modo diverso di concepire la politica, l’arte e la storia. È stato quindi un passaggio facile traslare il fallimento queer anche sul terreno dell’economia, della precarietà economica ed esistenziale, e intravedere nella crisi una possibilità di cambiamento o di espansione dei nostri modi obliqui di vivere e di pensare.
Sebbene nelle reti dell’attivismo transfemminista queer si fossero già sedimentate alcune riflessioni sull’intreccio fra produzione capitalistica e le nostre differenti collocazioni di genere e sessualità, è solo dopo il 2008, quando il debito e il fallimento diventano anche in Italia categorie dell’agitazione politica, che la prospettiva queer ci appare potenzialmente generalizzabile. […]
Alla fine del 2010, invitato al festival di cinema lesbico «Some Prefer Cake» organizzato da Luki Massa, Halberstam aveva presentato una raccolta di suoi saggi – tradotta per ETS da Federica Frabetti e pubblicata nella collana di studi queer curata da Liana Borghi e Marco Pustianaz – dal titolo Maschilità senza uomini, nella quale era inclusa una versione ridotta dell’introduzione di L’arte queer del fallimento. Ci era bastata questa suggestione, che associava il fallimento a un’arte, per iniziare a ragionare collettivamente – attingendo alla vasta gamma dei nostri fallimenti – su nuove forme di organizzazione politica e sociale e sui modi più adatti per rappresentare tutte le dimensioni soggettive, affettive, di genere che costituiscono il presupposto dell’essere messi al lavoro nella condizione queer precaria.
Fenomeni come l’aumento di suicidi fra i piccoli imprenditori in difficoltà economica all’inizio del 2012 e la «marcia delle (loro) vedove» nel maggio dello stesso anno, stavano tristemente lì a mostrarci come dietro alla categoria neutra universale di uomo-impresa si celasse la verità della cattura capitalistica, differenziale in base al genere, alla sessualità e alla «razza».
Il maschio bianco eterosessuale, proprio quello che in altri tempi avremmo definito borghese, era il nuovo soggetto dilaniato dalla crisi. Colui che si uccide per la vergogna di non poter adempiere al proprio ruolo di breadwinner mostrava l’insostenibilità delle aspettative sociali di genere, incarnando tragicamente la figurazione del fallimento. Colei che indossava gli abiti del lutto emergeva sullo sfondo di un esercito di donne pronte a «rimettere al mondo» la nazione, protagoniste del recupero neoliberale dei tradizionali ruoli di genere necessari alla giustificazione morale delle politiche di austerity: del resto, cosa c’è di più austero del lutto?
Per salvarsi, era necessario mettere in campo processi radicali di disidentificazione: il queer come elogio del fallimento all’assoggettamento eteronormativo, del fallimento rispetto all’appartenenza a docili identità di genere e alla relativa prescrizione di ruoli sociali ci sembrava potesse assumere una portata generale e generalizzabile. Si trattava in fondo di costruire un ponte tra l’«io non ho paura del default», l’arte queer del fallimento e il no future punk, come formula simbolica di una ricerca antisociale che fosse eminentemente politica, come prova a fare Halberstam con questo libro.
Nelle assemblee, nelle campeggie, nelle giornate di cospirazione frocia, nei collettivi sparsi in tante città e poi, a partire dal 2012, nella rete del Sommovimento NazioAnale, abbiamo provato a costruire un nuovo catalogo di rivendicazioni e pratiche politiche performative, sperimentazioni di welfare dal basso e neo-mutualismo queer. Abbiamo reclamato un reddito universale di autodeterminazione, nella consapevolezza che tutte le performance di genere sono esse stesse un lavoro. Abbiamo provato a praticare uno sciopero della (ri)produzione dei generi, intendendolo come dispositivo di disidentificazione sia dal lavoro che dai generi eteronormativi (e anche omonormativi e omonazionalisti). Cercavamo insomma di mettere a fuoco alcuni elementi di critica queer (per aggiornare il titolo di Mario Mieli) che potessero servirci a ricostruire un immaginario di liberazione ai tempi del default, a trovare un metodo per valorizzare le alternative ai sistemi egemonici a partire da ciò che già esprimeva una (r)esistenza. Alla mascolinità rispettabile (che contempla anche l’opzione suicidaria), andava opposta l’autodeterminazione come principio materialisticamente situato e radicale da contrapporre alla retorica liberale della libertà di scelta.
Favolose contro l’austerità, guardavamo anche al ruolo che femministe, froce, lesbiche e trans avevano negli spazi di autorganizzazione dei movimenti Decolonize/Occupy all’inizio degli anni Dieci: […] attraverso pratiche di azione diretta e di frivolezza tattica, il queer emergeva come un campo transnazioanale di intersezione tra soggettività lgbt e femministe, in grado di contestualizzare le lotte «specifiche» in un terreno di critica radicale all’organizzazione sociale, politica ed economica neoliberista.
Stavamo appena iniziando a confrontarci con i prodromi del populismo e del backlash neofondamentalista che ci aspettava, esito della ristrutturazione neoliberale post-crisi, ma per noi il fallimento era già uno stile politico. Da qui siamo partite e tornate, per cimentarci anche nel fallimento come stile teorico.
L’elogio del fallimento «perverso» di Halberstam del resto è anche una critica alle modalità di produzione e trasmissione del sapere tradizionalmente verticali e «certificate», sostenute dalle istituzioni accademiche, sempre più impastoiate in una ritualità disciplinare fine a se stessa.
Come l’autore ci ricorda, le istituzioni legittimate a produrre conoscenza egemonica come le università sorvegliano i saperi attraverso dispositivi chiave ormai ben noti: sistemi di valutazione e metodologie positiviste, canoni della memoria e archivi ufficiali. Sempre più centrale per il funzionamento di questi dispositivi è la cultura dell’eccellenza e della meritocrazia, giustificata per sanare la baronia, utilizzata per rendere strutturale il precariato, lo sfruttamento del lavoro gratuito, il disciplinamento dei saperi. Celebrare la stupidità contro l’eccellenza – come fa Halberstam – è allora un invito al pensiero queer, ovvero a trovare alternative che complicano i binarismi e le gerarchie di valore. […]
Già da prima, da sempre, l’attivismo, non solo transfemminista e queer, produce saperi «indisciplinati» che hanno lo stesso valore della produzione accademica: servono infrastrutture che se ne prendano cura dal basso e si preoccupino della loro libera circolazione, senza privatizzare (anche in senso economico) questa ricchezza comune.
Si tratta di evadere dallo schema che ci condanna all’autosottrazione e riproduce gli stessi meccanismi di (s)valutazione e oggettificazione di questi saperi, di continuare a sperimentare metodologie queer che rompano con la dicotomia dell’oggetto e del soggetto della ricerca, prendendo a modello quelle risposte «violente» e «negative» alle formazioni dominanti di sapere che Halberstam predilige.
Servono luoghi per organizzare collettivamente il rifiuto della «promessa di riconoscimento» sulla quale si basa tanta parte dello sfruttamento del lavoro intellettuale dentro e fuori l’accademia. Perché l’accademia, in questo senso, è solo un esempio e nemmeno il più importante.
E chissà, se da dentro una pandemia che imporrebbe a tutti di ammettere il fallimento, la rinuncia alla normalità come orizzonte, «abituarsi al buio» come dice Halberstam citando Quentin Crisp, non possa essere invece un modo condiviso per vedere le cose con più̀ chiarezza e non possa diventare un nuovo senso comune. […]
Saltata la sovrapposizione fra le cornici del successo economico, della soddisfazione lavorativa e familiare, l’alterazione delle routine del lavoro, del consumo e della riproduzione durante la pandemia ha prodotto un fenomeno di quitters che decidono di avventurarsi, anche solo temporaneamente, nei sentieri del fallimento. Un fenomeno che è stato definito come uno «sciopero generale non dichiarato», il cui fine è evidenziare come il lavoro contemporaneo, spesso sottopagato, precario, afflitto da continui tagli al personale, da un carico di lavoro troppo elevato e da una cultura del lavoro tossica, sia diventato insostenibile. In maniera simile, la pratica dello «sciopero dei e dai generi», che dagli anni Dieci ha punteggiato i movimenti transfemministi queer, vuole rappresentare l’insostenibilità dell’economia dell’eterosessualità, basata su differenziali di potere ingiustificabili, rinunce e sacrifici inutili e dannosi, performance di genere tossiche e violente, e il nostro diritto a essere choosy, a poter scegliere quali corpi, pratiche e piaceri sperimentare e affermare, a sottrarci all’austerity non solo economica, ma anche di generi e sessualità.
Come dicono le quitters in alcune interviste, l’idea di dimettersi è contagiosa: è attraverso l’esempio di altr_ collegh_ che ha preso forma l’idea di lasciare il lavoro, anche senza la certezza di trovarne un altro: «Quando falliamo, siamo in ottima compagnia».
Più volte, in questi anni, ci siamo soffermate a contemplare cosa potrebbe accadere se ci dimettessimo, tutte insieme, dall’economia eterosessuale, dai nostri ruoli di genere e dal lavoro di riproduzione non pagato, da tutti i nostri lavori precari, dall’università neoliberista e dalla valorizzazione aziendale della nostra favolosità frocia. Dory e la gallina Gaia, o gli atleti che si piazzano al quarto posto, ci ricordano «che c’è qualcosa di potente nello sbagliare, nel perdere e nel fallire» e che, per parafrasare ancora Halberstam, tutti i nostri fallimenti, se vissuti oltre la dimensione individuale, «potrebbero bastare, se li pratichiamo bene e insieme, a buttare giù i vincitori».
Oggi, come dieci anni fa, siamo di nuovo di fronte a un bivio: aggrapparsi ai resti, alle macerie del patto sociale novecentesco o tentare di fare uno scarto, risignificando e riappropriandoci del discorso sul fallimento come rifiuto dell’etica capitalistica e del suo contraltare di compatibilità, il lavorismo, che è stato così caro alla sinistra storica, a partiti e sindacati, ed è riemerso nella poverofobia che ha caratterizzato le recenti richieste di abolizione del reddito di cittadinanza.
Il no future punk queer non è solo rifiuto del futurismo riproduttivo familista (che è parte integrante anche di una certa retorica della rispettabilità precaria, che richiede reddito per accedere a un mutuo e mettere su famiglia) in nome del godimento qui e ora, ma anche rifiuto della (ri)produzione sociale, dell’organizzazione gerarchizzata della società. Se l’a-venire è già predeterminato, la temporalità che vogliamo abitare è ovviamente il presente.
Estratto da FALLIRE, SEMPRE MEGLIO. Postfazione a L’arte queer del fallimento di CRAAAZI – Centro di ricerca e archivio autonomo transfemministaqueer Alessandro Zijno, Minimum Fax, 2022
immagine di copertina foto Jack Halberstam, di Joe Mabel
Jack Halberstam è presente a Short Theatre 2022 venerdì 16 settembre, a WEGIL, con una lectio magistralis Wild Things, Bewilderment and Beyond, accompagnato e in dialogo con l’attivista e studiosa Antonia Anna Ferrante e con Annalisa Sacchi, direttrice del corso di Teatro e Arti performative di IUAV e sabato 17 settembre all’Angelo Mai, nella cornice di MERENDE in occasione della presentazione del suo libro The Queer Art of Failure.
VIANDANZE è la sezione di CUT/ANALOGUE delle scritture in interdipendenza dinamica con le pratiche artistiche e le opere presenti al festival (e altrove). Propone una forma di prossimità somatica tra chi osserva e chi è osservato per far balenare pensieri sul sensibile che avviene in scena.