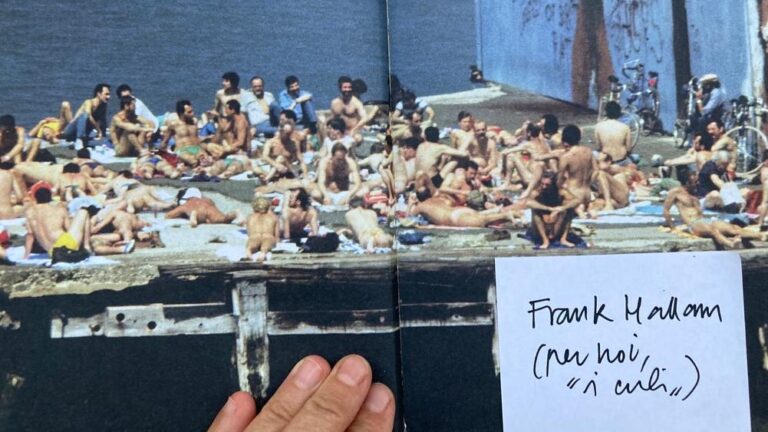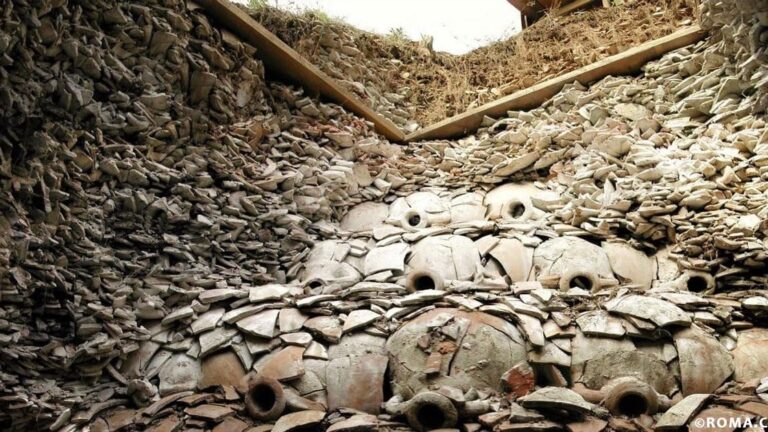di Erin Manning
L’artista e filosofa politica canadese, Erin Manning scrive un testo dopo aver assistito a deader than dead di Ligia Lewis, lavoro concepito nel 2020 in occasione di Made L.A che, a causa della pandemia, diventa una creazione filmica. Il terrore dell’accesso è una scrittura reattiva, uno scambio privato tra Manning e Lewis – o come lo definisce l’autrice – non un tentativo di interpretazione, ma una forma-sentimento.
∴
Io sto con deader than dead. Scrivo “Dread” (terrore). Deader than Dread (più morto del terrore). Si coglie un senso d’orrore, è il rischio di viverlo fino in fondo. Ho la percezione di una terza presenza – un terzo personaggio. Sono attratta dal modo in cui i movimenti orientano o disorientano. Percepisco una sorta di disagio.
Vorrei riflettere su come il lavoro convochi l’“entrare”, vorrei partire da quel richiamo a un’idea di “accesso”. Ciò che ci ha spinto in questo dialogo, è stata proprio questa domanda: chi entra e come, o piuttosto cosa mette in scena l’ingresso? Forse in questo consiste il terrore. Intendo dire che non è fornita una visione complessiva del lavoro, né sono invitata “fino in fondo” a entrare. Per accedervi è necessaria una modalità diversa rispetto alla sola visione, credo.
Qualcosa nella pronuncia bisbigliata di «e… domani… e» e in «e… il fatto», che compare verso la fine, suggerisce che quell’ellissi ha la forza di un incontro che non è “per tuttə”. Cosa significa questo “per tuttə”, o cosa protegge la sua assenza. È un modo indiretto di dire che mi rendo conto della mia bianchezza nell’incontro con il campo della percezione. Deader than Dead minaccia di “farmi entrare” nella mia pelle bianca. Il terrore: quello che mostra la mia appartenenza a un luogo di privilegio legato alla bianchezza. Tenterò comunque di entrare da questa posizione. Che lo farò per me stessa. Ma non avrei dovuto preoccuparmi. Il lavoro non parla di me. O meglio, non è rivolto alla bianchezza e, in ogni caso, devo smettere di orientare tutto attorno all’“io”, quell’abitudine endemica dei bianchi di personalizzare ogni cosa. La personalizzazione nella bianchezza – compreso il suo senso di vergogna e mea culpa tipico della sinistra – è mortale. Perché, là dove ci congratuliamo con noi stessi per aver compreso le differenze, abbiamo in realtà messo in scena un vicolo cieco. Questo vicolo cieco si chiama “accesso”. L’accesso è esattamente ciò che l’opera rifiuta. Mi interessa il rifiuto.
Penso al mio amico John Lee Clark e al suo bellissimo pezzo Against Access. John Lee Clark è un poeta e saggista sordo-cieco, uno dei primi oratori e inventori di una nuova lingua/cultura sordo-cieca chiamata ProTactile. In Against Access, John riflette su come le persone vedenti/udenti si premurino di “dargli” accesso. È interessato (e sconcertato) dal quel desiderio di “dare” “accesso” come “la” condizione per un vero possibile incontro con il mondo.
Quali presupposti sottostanno alla convinzione che bianchezza (abilismo e neurotipicità) siano “il” luogo verso cui far convergere una partecipazione sempre in deficit? Perché John dovrebbe voler partecipare in modo indiretto a un mondo che lo “adatta” a sé? La sua posizione mi ha insegnato molto. Sull’alt-text (la scrittura di didascalie sul video) afferma:
Negli ultimi anni, c’è stato un gran da fare in Internet per produrre le didascalie descrittive delle immagini, spesso criticando coloro che non le usano. Potrebbe essere un esempio di responsabilità comune in azione, ma è sorprendente osservare che la maggior parte delle persone che si prodigano in feroci rimproveri o suggeriscono correzioni sono vedenti. Questi sforzi sono in gran parte controproducenti. Non riesco a contare quante volte ho smesso di leggere una trascrizione video perché iniziava con una descrizione troppo dettagliata. Anche se una descrizione è breve e ben fatta, spesso preferirei che non ci fosse alcuna descrizione. Vai al punto, per favore! È ironico che la ricerca dell’accesso possa effettivamente creare una barriera. Quando l’ho fatto notare, durante uno dei miei seminari, un partecipante ci ha fatto ridere facendo una parodia: «Mary indossa una maglietta a strisce verdi, blu e rosse; ogni quarta striscia ha anche un puntino viola delle dimensioni di un pisello, e ci sono quarantasette strisce…».
«Mi stai uccidendo» – ho detto – «Basta, non ne posso più!».
John sottintende una domanda: quale mondo promette questo accesso? L’accesso, a dispetto delle sue buone intenzioni, riconduce a un orizzonte normativo, a quel luogo che si presuppone coincida con “il” mondo. Quanta presunzione!
Dov’è la possibilità per altre modalità di percezione o altri modi di entrare nello spazio della convivialità? Per altri mondi? Perché dare per scontato che l’ambiente normativo in cui viviamo miseramente – e in cui la bianchezza, l’abilismo, la neurotipicità e le tutte le forme di colonialismo proliferano per mano del capitalismo razziale – sia il luogo, proprio questo, predefinito dell’incontro??? Possiamo con certezza concordare che sia un luogo in cui la vita sta morendo? Mettere in discussione l’accesso, come vedo nella tua performance, Ligia, non significa necessariamente orchestrare un rifiuto frontale. Può essere un rifiuto generativo, nel senso suggerito da Tina Campt e Saidiya Hartman. Campt si chiede: «Come possiamo scrivere, pensare, eseguire, praticare, visualizzare, coinvolgere, teorizzare, raccontare o mettere in atto una pratica di rifiuto?». Una pratica di rifiuto – per come la intendo – mette l’accento sulla pratica stessa. Il rifiuto sta nella pratica. «Per noi “praticare il rifiuto” rivela l’urgenza di ripensare il tempo, lo spazio e il vocabolario di base della politica, dell’attivismo e della teoria, e anche cosa significa “rifiutare” i termini imposti per nominare queste lotte».

In deader than dead scorgo la drammaturgia del peso-del-corpo. È un modo strano di dirlo – mi chiedo se ti risuona – ma percepisco che i corpi sono più peso che forma, più forma che individuo. A volte in modo limpido, a volte con agilità, a volte con un tipo preciso di coordinamento, a volte in dissolvenza, i corpi rivelano forme di esistenza, più che persone che danzano. Non vuol dire che non c’è una singolarità nel movimento, ma una qualità diversa in ciascuno dei corpi. E anche una forte sensazione di terzietà – lo accennavo all’inizio – una qualità diffusa che suggerisce un +1, “uno” in più rispetto all’uno. È come se ci fossero strati di esistenza, e la danza sia il modo in cui gli strati si intrecciano (non sono semplicemente “messi in scena”). Ciò che viene percepito in questa modulazione è una sorta di qualità indicativa, indicativa nel senso che la terzietà spinge verso una sensazione diffusa o ambientale, non esattamente orientata al linguaggio o al senso. Il linguaggio è presente, e sentiamo le parole, ma in qualche modo è l’ellissi che risalta…
Connesso a questo aspetto, c’è il fatto che i corpi assumono altre posture. Ci sono le istanze di un corpo nero o del corpo nero, ma nella performance colgo piuttosto una sorta di tremore? Quel momento in cui i corpi sono ammassati ha la qualità della nerezza che si è fatta essa stessa corpo. Questo “diventare corpo” è aperto all’accesso. È il momento nel pezzo in cui la bianchezza è riconosciuta. Il nero come il meno-dell’uno, l’ammonticchiato, la cosa. Ma non il futuro. Anche qui l’accesso non è accordato. Non per davvero. Perché il movimento continua a prodursi e presto ci sarà quell’azione intensamente collettiva dove l’effetto di sfarfallio riconduce l’ambiente a una sensazione di luce e buio, dove i corpi si muovono all’unisono, un unisono di stratificazione sonora, molteplicità di forme, peso e bagliore. Questa concertazione non è a buon mercato. Non è un dato di fatto.
Questi intrecci creano mondi che compulsano complessità nell’esistente. Un varco per il consumo dei corpi neri è stato momentaneamente aperto, e poi ti sputa fuori. O ti adegui o rimani esposto alla luce abbagliante. Questo non riguarda solo noi, proprio noi. Quando la parrucca viene rimossa, si genera un altro corpo. È un momento di individualità, ma non appare un’identità predefinita, come se la nerezza fosse già bella e pronta. No. La corporeità che emerge, che è singolare, che “spicca”, è un affronto a qualsiasi presunzione. È sfidante.
Questa non è un’interpretazione. È una forma-sentimento su come deader than dead provochi un senso di terrore, su come plasmi un mondo che resiste. Che rifiuta una facile organizzazione, che rifiuta quella separazione banale messa in scena nell’affronto con un o il corpo nero. La sfida è lì, frontale nel rifiuto di ogni modesto tentativo di collocare, confinare, posizionare. La nerezza è molto di più del corpo nero, molto di più di ciò che viene catturato, assassinato, reso accessibile. La nerezza è la forma di altri modi di esistenza, esistenze inaccessibili. Inaccessibili per la bianchezza.
La bianchezza presuppone di avere gli strumenti per l’accesso. La parola che offre per questo è “empatia”. Mi rifaccio sempre a Saidiya Hartman quando penso alla forza distruttiva dell’empatia. In Scenes of Subjection, sottolinea che l’empatia è un sentimento per sé stessi. È un meccanismo di proiezione di sé che favorisce il proprio riconoscimento: «L’empatia è una proiezione di sé nell’altro, al fine di comprendere meglio l’altro o “la proiezione della propria personalità” su un oggetto, attribuendo all’oggetto le proprie emozioni». Ho riflettuto molto su questo aspetto anche in relazione alla neurotipicità e ho scritto sui limiti dell’umanesimo che non tiene conto delle complesse modalità della percezione autistica. Sentire-con non è empatia. Sentire-con significa essere trasformati, essere plasmati dall’incontro.
Nell’analisi di Hartman, l’empatia emerge nei comportamenti degli abolizionisti come Rankin. «[N]el far propria la sofferenza dello schiavo, Rankin si ritrova a esperire le loro pene, focalizzandosi su se stesso anziché sulle persone per le quali quell’esercizio di immaginazione era stato presumibilmente concepito. Inoltre, sfruttando la vulnerabilità del corpo prigioniero come recipiente per gli usi, i pensieri e i sentimenti degli altri, l’umanità estesa allo schiavo conferma involontariamente le aspettative e i desideri che definiscono le relazioni schiavistiche. In altre parole, la facilità con cui Rankin si identifica empaticamente è dovuta tanto alle sue buone intenzioni e alla sua sincera opposizione alla schiavitù quanto alla intercambiabilità del corpo prigioniero». L’empatia amplifica la sostituibilità del corpo per il tramite dell’accesso, stabilendone la condotta.
Se deader than dead non vuole dare accesso, cosa c’è in gioco? Si sta muovendo in direzione di nuovi campi del percepire attraverso l’attività, la pratica. Non è interessato a te, a me, o qualunque cosa significhi. È interessato alla nerezza, al suo ritmo e alle sue forme, a ciò che evoca e respinge, a ciò che reclama ma che non soddisfa. Deader than dead non è il resoconto di “un” corpo nero o “del” corpo nero, perché quello non è semplicemente il suo registro. Il suo registro non è quello dell’empatia. Il percorso che propone è la pratica. Suggerisce un ritmo nel guardare diversamente in modo che, quando la parrucca cade, siamo spinti a prendere in considerazione il nostro sguardo, il nostro essere-con, accanto. Ma non a noi stessi. Questo non è l’obiettivo. Perché questo noi può essere solo legato alla bianchezza che presuppone sempre di avere l’ultima parola su cosa sia un corpo.
La potenza, la forza evocativa, il terrore di deader than dead è che continua a vivere senza di noi, se quel noi è una forma di ripiegamento verso sé stessi. La nerezza è molto di più di quel limitato involucro di interpersonalità. La nerezza è tra, attraverso, da scoprire, da danzare. È da praticare nel rifiuto.
Ringraziamo Erin Manning per averci concesso di pubblicare Il terrore dell’accesso in CUT/ANALOGUE in occasione del PRISMA dedicato a Ligia Lewis. Il film deader than dead sarà proiettato durante il festival mercoledì 13 settembre, seguito dal talk con l’artista Una Coreografia Fuggitiva.
traduzione di Piersandra Di Matteo
Erin Manning è una teorica culturale e filosofa politica canadese e artista attiva nei campi della danza, del design tessile e dell’installazione interattiva. Agisce negli spazi interstiziali tra filosofia, estetica e politica, con uno spiccato interesse per le pratiche pedagogiche. Titolare della cattedra di Speculative Pragmatism, Art and Pedagogy all’Università Concordia (Montreal, Canada), è fondatrice del SenseLab (www.senselab.ca), laboratorio che esplora le intersezioni tra pratica e teoria attraverso la matrice del corpo in movimento. La sua ricerca artistica è orientata alle relazioni e agli intrecci, spesso in chiave partecipativa, giocando in modo sinestetico con il tatto, sperimentato nel movimento ProTattile per la cultura e il linguaggio DeafBlind. Le sue mostre hanno avuto luogo alla Biennale di Sydney, Glasshouse (New York), Vancouver Art Museum, McCord Museum (Montreal), House of World Cultures (Berlino) e Galateca Gallery (Bucarest).
Tra le pubblicazioni: Out of the Clear (di prossima uscita), For a Pragmatics of the Useless (2020), The Minor Gesture (2016), Always More Than One: Individuation’s Dance (2013), Relationscapes: Movement, Art, Philosophy (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2009) e, con Brian Massumi, Thought in the Act: Passages in the Ecology of Experience (2014).
Il terrore dell’accesso è un contributo di
PRISMA – Complaint, A Lyric
Ligia Lewis nella città di Roma
VIANDANZE è la sezione di CUT/ANALOGUE delle scritture in interdipendenza dinamica con le pratiche artistiche e le opere presenti al festival (e altrove). Propone una forma di prossimità somatica tra chi osserva e chi è osservato per far balenare pensieri sul sensibile che avviene in scena.
ph Cordoba Roberto Ruiz